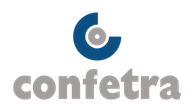ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it
Bollettino ADAPT 4 marzo 2024, n. 9
Eventuali erogazioni in forma di welfare a lavoratrici madri, durante il periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, per un valore corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale costituiscono reddito di lavoro dipendente e non godono delle esenzioni fiscale previste dal comma 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. Questo, in sintesi, è quanto stabilisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 57 del 2024.
Innanzitutto, occorre osservare che l’impresa istante non prevede semplicemente di riconoscere delle specifiche misure di welfare alle lavoratrici, ma dichiara espressamente di voler riconoscere una somma a integrazione del 100% della retribuzione mensile lorda, facendolo tuttavia non attraverso la retribuzione monetaria ma in forma di welfare aziendale. Quindi, l’azienda esplicita l’intenzione di erogare misure di welfare in sostituzione di elementi retributivi.
L’Agenzia delle Entrate si è già più volte espressa su tale questione ribadendo il “principio di infungibilità” tra retribuzione e benefit o misure di welfare, poiché tale sostituzione si tradurrebbe in un aggiramento dei criteri di formazione del reddito di lavoro dipendente e del principio di onnicomprensività del reddito, stabilito dal comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, per cui «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» tranne per le tassative eccezioni previste dai commi successivi al comma 1 dell’articolo 51 del TUIR.
La Risoluzione n. 55 del 2020 sottolinea, infatti, che le disposizioni di esenzione dal reddito «non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati». L’unica eccezione ammessa è la possibilità di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare, ma anche in questo caso è possibile soltanto in base a quanto prevede strettamente la normativa.
Pertanto, «qualora tali benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori)», compresa quindi la sostituzione di quote della retribuzione con misure di welfare o benefit, «il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione» (v. Risposta a interpello n. 57/2024 e con le medesime parole Risoluzione n. 55/2020).
In considerazione di quanto esposto, non sorprende la risposta della Agenzia delle Entrate, per quanto attiene a questo profilo, perché è chiara la volontà dell’azienda di sostituire retribuzione con prestazioni di welfare e è altrettanto indiscussa l’impossibilità di tale sostituzione o, in ogni caso, l’assoggettamento dei relativi valori a imposizione contributiva e fiscale.
Più discutibile e meno argomentata pare essere la conclusione dell’Agenzia delle Entrate rispetto al fatto che lo «status di maternità» non sia idoneo a individuare una ”categoria di dipendenti” destinataria di misure di welfare al fine dell’esenzione dal reddito ai sensi del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR.
Innanzitutto, occorre sottolineare che non è del tutto chiaro a cosa si riferisca l’Agenzia con l’espressione «status di maternità», se alla condizione della lavoratrice madre o se invece alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria per maternità o astensione facoltativa o per meglio dire in congedo parentale. Invero, la casistica presentata dalla azienda istante riguardava, appunto, lavoratrici madri che «usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale» (così la descrizione del caso nella Risposta a interpello in oggetto). Si ritiene, pertanto, che con l’espressione sintetica «status di maternità» che l’Agenzia si volesse riferire al periodo di astensione dal lavoro legato alla maternità.
L’Agenzia delle Entrate assume la posizione sopradescritta, sostenendo che non sia «possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente». L’Amministrazione finanziaria arriva a questa affermazione, soltanto ricordando, che «l’espressione ”categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo ”tipo” o di un certo ”livello” o ”qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ”utilità” previste» – richiamando, come in molte altre occasioni, diversa prassi amministrativa (circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 e 16 luglio 1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 16 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018 n. 5/E).
Non solo la conclusione pare non sufficientemente argomentata, basandosi soltanto sui principi sopraesposti. Ma, mostra, quanto meno, un certo grado di incoerenza con precedenti conclusioni. In particolare, la risposta ad interpello n. 273 del 2019 riconosce come categoria omogenea un gruppo di lavoratori a «maggior rischio di non impiegabilità, nonché in situazione di maggior fragilità sociale», costruito su «valutazione […] legata a diversi fattori, soggettivi e oggettivi». La società istante spiega che «l’idea di fondo è che lo svantaggio sia dovuto alle caratteristiche che rendono più probabile la permanenza nella condizione di disoccupazione e non a quelle che determinano il verificarsi della disoccupazione (non il perché una persona è disoccupata, ma cosa la fa rimanere disoccupata a lungo)». Inoltre, viene sottolineato che le caratteristiche considerate per valutare il rischio di non impiegabilità e la fragilità sociale «sono sia individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale)».
Se confrontiamo quanto ammesso per la categoria di lavoratori “a maggior rischio di non impiegabilità,” con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella nuova risposta di interpello in commento, emerge uno scostamento.
Come visto, l’impiegabilità è valutata su caratteristiche, sia «individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale)». Si tratta di criteri basati, quindi, su «caratteristiche o condizioni personali» o eventualmente territoriali e di contesto, ma in ogni caso non sono comunque riconducibili all’ambito della prestazione di lavoro, preso a riferimento come criterio dalla nuova posizione della Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate riconosce come “categoria di dipendenti” l’insieme di lavoratori che, avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare, ricevono una “quantità” di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio convertito (circolare n.5/E del 2018). Anche in questo caso, non sembra potersi dire che la categoria sia costruita sulla base di criteri legati alla prestazione lavorativa, infatti è legata alla volontà e dalla scelta dei lavoratori di convertire il premio di risultato in welfare.
Potrebbe nascere il dubbio che l’Agenzia delle Entrate neghi la categoria di dipendenti basata sullo «status di maternità», perché potrebbe essere considerata discriminatoria sulla base del genere. L’Agenzia avrebbe potuto eventualmente specificare che sarebbe stato corretto una categoria più generale costituita da lavoratori o lavoratrici che si avvalgono del congedo parentale. Tuttavia, non è stato esplicitato questo argomento, mentre il discrimine è stato individuato nell’assenza di collegamento con la prestazione lavorativa.
In sintesi, per quanto si è cercato di argomentare, lascia una certa perplessità la posizione dell’Agenzia delle Entrate che ritiene di disconoscere lo «status di maternità» come categoria omogenea ai fini dell’applicazione dell’esenzione dal reddito, se destinataria di misure di welfare erogate ai sensi del comma 2, dell’articolo 51 del TUIR.
Silvia Spattini
Ricercatrice ADAPT @SilviaSpattini
@SilviaSpattini